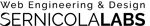Reddito di cittadinanza, stimolo o disincentivo al lavoro?
formazione, lavoro, persone, reddito di cittadinanza
L’introduzione del Reddito di cittadinanza in Italia continua a dividere l’opinione pubblica, che si interroga sulla reale utilità del provvedimento per rilanciare il mercato del lavoro. L’ultimo allarme è stato lanciato da Confindustria, che ha evidenziato il rischio che la misura fortemente voluta dal Governo possa scoraggiare le persone nella ricerca di un impiego, in quanto la somma di 780 euro prevista dalla misura non sarebbe così distante dallo stipendio medio di un giovane Under 30 (830 euro, come calcolato dall’area Lavoro e Welfare di Confindustria).
In Occidente la situazione non è nuova: come ha scritto su Persone&Conoscenze il ricercatore Riccardo Evangelista, già a fine ‘700 in Inghilterra era stato sperimentato un sussidio per gli abitanti di una cittadina del Berkshire che integrasse il loro salario.
I magistrati inglesi, turbati dalla povertà dei molti che non riuscivano a trovare un lavoro in grado di sostenere se stessi e le proprie famiglie, decisero di garantire il diritto di vivere a tutti i cittadini attraverso l’erogazione di un sussidio universale che integrasse il salario qualora questo fosse sceso al di sotto di un certo livello, stabilito in relazione al prezzo del pane. Quello che venne salutato dai filantropi come un provvedimento di grande umanità e dai più cinici come un atto deplorevole, ma tutto sommato necessario, si trasformò ben presto in un incubo.
Meglio il sussidio del salario
Della vicenda del ‘Reddito di cittadinanza’ ante litteram ne scrive lo storico dell’economia Karl Polanyi nella sua opera più importante, La grande trasformazione: “Alla lunga il risultato fu agghiacciante. Per quanto occorresse del tempo affinché il rispetto dell’uomo comune cadesse così in basso da preferire il sussidio per i poveri al salario, i salari che venivano integrati per mezzo di fondi pubblici erano in numero illimitato tanto da spingere le persone a sostenersi con esso. Poco a poco la gente della campagna fu immiserita, l’adagio ‘una volta il sussidio, sempre il sussidio’ era una verità”.
Nonostante il riferimento sia a un esperimento circostanziato di oltre due secoli fa (la legge sui sussidi venne abolita definitivamente nel 1834), la disamina tocca almeno due questioni, strettamente connesse, che ancora oggi sono tra le più rilevanti nel valutare i possibili effetti dell’istituzione di un reddito minimo garantito: la presunta tendenza dei beneficiari a preferire il sussidio al salario e la sostenibilità economica di un provvedimento così ampio.
L’esperimento finlandese
Ci sono però altri esempi di sussidi ben più recenti che si sono rivelati fallimentari. Il caso più noto è quello della Finlandia, dove da gennaio 2017 era iniziata la sperimentazione di un reddito di cittadinanza incondizionato da 560 euro mensili in sostituzione dell’indennità di disoccupazione su 2mila cittadini disoccupati o a reddito basso.
L’esperimento è terminato a fine 2018 e i risultati sono stati presentati a febbraio 2019 dal Governo finlandese: è emerso che il reddito minimo garantito ha migliorato la salute e l’equilibro psichico dei beneficiari, ma non ha facilitato la ricerca di un nuovo impiego. Lo stimolo a trovare un nuovo lavoro, quindi, non si è rivelato più efficace rispetto a quello dei disoccupati che non hanno partecipato al test.
Come ha scritto su Persone&Conoscenze Chiara Saraceno, Professoressa di Sociologia della famiglia dapprima all’Università di Trento, poi all’Università di Torino, l’esperimento finlandese è stato una sorta di compromesso: non era un reddito di cittadinanza universale, perché destinato ai disoccupati in sostituzione dell’indennità di disoccupazione. Tuttavia era simile a un reddito di cittadinanza in quanto, a differenza sia dell’indennità di disoccupazione sia del reddito minimo per i poveri (che pure in quel Paese esiste), non poneva condizioni per riceverlo: infatti i beneficiari, per tutta la durata della sperimentazione (un anno), non sono stati obbligati a effettuare, documentandole, specifiche azioni di ‘attivazione’ e di ricerca di lavoro, tantomeno ad accettare qualsiasi lavoro venisse loro offerto pena la perdita dell’assegno.
Sfruttare il tempo libero per formarsi
La sperimentazione consisteva proprio nel vedere se, liberi da questi vincoli e con un assegno sufficientemente generoso da non obbligarli ad arrabattarsi per integrarlo o farlo bastare, i beneficiari fossero in grado di sfruttare il tempo loro concesso per migliorare il proprio capitale umano e le proprie condizioni di occupabilità, per avviare iniziative imprenditoriali, per trovarsi un lavoro soddisfacente. Era una scommessa sulla capacità delle persone, messe nelle condizioni giuste, di trovare la propria strada senza bisogno che qualcuno le controlli e le stimoli.
Il provvedimento, però, si è dimostrato inefficace per promuovere l’aumento del tasso di occupazione.
Il punto centrale riguarda quindi le persone: i beneficiari del Reddito di cittadinanza saranno capaci di utilizzare al meglio il tempo a disposizione (mentre ricevono il sussidio) per investire nella propria formazione, migliorare le proprie competenze e trovare un nuovo lavoro?
Il tema del futuro del lavoro è approfondito nel numero di Gennaio-Febbraio 2019 di Persone&Conoscenze.
Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)